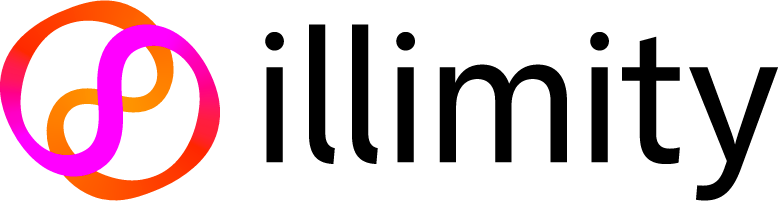CEO illimity
Alcuni giorni fa, ho avuto il piacere di partecipare, insieme a Lorenzo Fioramonti, Rossella Muroni, Mario Antonio Scino ed Enrico Giovannini a un convegno organizzato dal Centro GREEN dell’Università Bocconi sul tema: “Il mondo dopo il PIL”, ossia su valore e peso che viene attribuito al PIL come super indicatore.
Le critiche che in questi anni si sono accumulate sul #PIL sono numerosissime e in gran parte giustificate. Se ne parla da decenni, tanto che tutti ricordano la famosa critica che Robert Kennedy lanciò contro il PIL già cinquant’anni fa.
Più interessante è forse chiederci perché, malgrado le tante critiche, il PIL sia ancora vivo e vegeto: ogni trimestre le sue variazioni, anche di pochi millesimi, scatenano discussioni di ogni tipo nel mondo politico e in quello finanziario. Sono stati fatti diversi tentativi di sostituire il PIL con altri indicatori, ma nessuno è riuscito a mandarlo in pensione: non è stato trovato un altro super indicatore sintetico migliore del PIL e non si è imposto nessuno dei panieri di indicatori che negli anni sono stati proposti (spesso troppo complessi e senza robuste serie storiche confrontabili internazionalmente).
A mio parere, peraltro, il PIL va mantenuto, corretto e integrato.
Il PIL va mantenuto, se pur corretto, perché è un indicatore della #crescita difficilmente rimpiazzabile: la crescita è condizione per la sostenibilità, prima di tutto di quella sociale. Diversamente detto: la decrescita avrebbe un effetto devastante su quest’ultima.
Il PIL va corretto. A differenza di quanto viene suggerito da molte parti, non aggiungerei al computo del PIL il lavoro gratuito e l’economia del dono (il cosiddetto terzo settore) perché porterebbe a risultati concretamente poco utilizzabili e confrontabili. Piuttosto, eliminerei dal computo del PIL l’economia informale e quella criminale: è assurdo che si possa considerare positivo un PIL che cresce grazie all’aumento di tali componenti.
Il PIL va integrato, con indicatori capaci di rappresentare le altre dimensioni della #sostenibilità. Per renderli rilevanti e universali, dobbiamo assicurarci che tali indicatori siano pochi, semplici e ricostruibili ovunque. Per tener conto della sostenibilità sociale, per esempio, potremmo aggiungere un indicatore della povertà (che, per quella assoluta, punti all’obiettivo nel tempo dello 0 per cento) e per tener conto della sostenibilità ambientale potremmo aggiungere un indicatore di quanto le energie rinnovabili incidano sul totale (in questo caso l’obbiettivo nel tempo dovrebbe essere del 100 per cento). Per tener conto della sostenibilità finanziaria ci vorrà un indicatore di indebitamento mentre per misurare l’effettiva produttività dei fattori nel mondo delle nuove tecnologie ci vorrà un premio Nobel vista l’inadeguatezza delle attuali misurazioni.
Si tratta solo di alcuni esempi e se ne possono certamente trovare altri e di migliori, ma questa è la direzione da seguire. L’opinione pubblica e i media possono fare molto per spingere in questa direzione e, sulla base di questi indicatori, selezionare una classe dirigente da cui pretendere impegni precisi in tal senso.
Il PIL è considerato la bandiera del sistema capitalistico nel quale viviamo e, quindi, il dibattito sul PIL si porta dietro una domanda di fondo: il capitalismo è un sistema economico da accantonare o da correggere? Porci di fronte a questo tema con obiettività è doveroso, visto che viviamo nell’era del capitalismo e il malessere sociale nei nostri Paesi è in aumento, anche a causa di crescita e offerta di lavoro insufficienti e diseguaglianze sociali che si fanno insostenibili.
In Occidente abbiamo assistito negli anni alla diffusione di diverse forme di capitalismo e, negli ultimi decenni, ha finito per prevalere l’approccio neoliberista: una versione del capitalismo che ha esasperato i tratti più estremi del capitalismo stesso e il cui dogma – il mercato ha sempre ragione – è stato spazzato via solo in parte dalla crisi del 2008-2009.
La mia tesi, piuttosto, è che se per capitalismo intendiamo il sistema economico che promuove e protegge la libera impresa e il libero mercato, tutelando la proprietà privata e imponendo regole uguali per tutti, allora il capitalismo possa essere corretto e non vada accantonato.
I malesseri che affliggono le nostre società hanno radici profonde che non dipendono solo dal sistema economico: timori e incertezze che serpeggiano soprattutto nelle categorie sociali più deboli sono legati anche alla conflittualità economica tra grandi nazioni che minacciano la pace, all’impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro, alla pressione esercitata sul welfare dall’invecchiamento progressivo della popolazione e ovviamente ai mutamenti climatici che minacciano la sopravvivenza stessa del pianeta.
L’evoluzione del nostro sistema economico non può che essere in quello che definisco Capitalismo Responsabile, ovvero un sistema economico capace di trasformare le sue enormi potenzialità in energia ed esternalità positive:
· socialmente responsabile e capace di ridurre le diseguaglianze e i malesseri già citati;
· ecologicamente responsabile e impegnato a non consumare in maniera dissennata le risorse naturali del nostro pianeta;
· finanziariamente responsabile e attento a non promuovere una crescita basata sull’aumento incontrollato del debito.
Gli esempi di questo Capitalismo Responsabile non mancano: illimity ne ha fatto il suo motto. Facciamo credito a PMI che hanno potenziale inespresso, che hanno incontrato qualche difficoltà ma possono rilanciarsi, o che sono andate male ma possono ancora esprimere valore. Ci sono tanti imprenditori illuminati, ma la loro buona volontà non può bastare: serve un cambiamento profondo che contemperi questa visione di sistema e le istanze provenienti da tutta la società.
Per avviare questo cambiamento servono regole adeguate e meccanismi efficaci per farle rispettare. Le aberrazioni dell’attuale sistema sono sotto gli occhi di tutti, arginarle potrebbe generare un immediato impatto positivo e strutturale: dalle normative antitrust (che dovrebbero evitare pericolose concentrazioni di potere soprattutto nell’ambito delle mega società tecnologiche) alle normative sulla privacy (che dovrebbero evitare l’intromissione quotidiana che condiziona pensiero e comportamento di miliardi di persone). Senza contare la spinosa questione dei paradisi legali, terreno su cui prospera la criminalità e cresce immensa l’evasione fiscale.
Al Capitalismo Responsabile servono politiche economiche in grado di assicurare una crescita sostenibile, di riattivarla come nel caso della stagnazione attuale. Periodi prolungati di stagnazione o recessione producono effetti devastanti sul welfare, che già fa i conti con l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della disoccupazione. L’austerità, da sola, non è la ricetta giusta: la storia ci ha insegnato che servono politiche monetarie accomodanti, ma soprattutto politiche di investimento coraggiose che puntino su innovazione, istruzione e infrastrutture.
Il Capitalismo Responsabile ci pone una vera e propria sfida culturale sul significato e sulle componenti del bene comune. Basta considerare quest’ultimo come una specie di effetto automatico che deriverebbe del contrapporsi di interessi personali, come una visione banalizzante delle teorie di Adam Smith sembrano suggerire: il bene comune non può che venire da una responsabilità condivisa dell’intera classe dirigente. Il bene comune non può essere perseguito all’interno di sistemi chiusi: qualcuno può pensare che singole nazioni possano evitare il riscaldamento globale o sconfiggere le reti di criminalità internazionali? Il bene comune rifugge dalle banalizzazioni e dalla ricerca costante di un nemico da colpevolizzare per tutti i nostri problemi. Il bene comune ha bisogno di visione a lungo termine, dei già citati investimenti strutturali in innovazione, istruzione e infrastrutture: nulla a che fare con lo shortermismo che caratterizza ormai quasi tutti i comportamenti economici e politici.
Andare oltre il PIL è dunque necessario: ma, come abbiamo visto, è solo un tassello di un mosaico di cambiamenti più ampio. È un passo su una strada lunga, ma necessaria: una strada non facile e che non prevede scorciatoie.